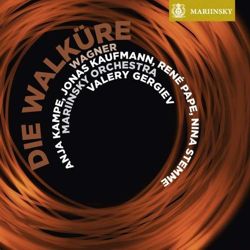
Rivelandosi padrone del fraseggio wagneriano ben più che non si
reputasse, Gergiev approda al secondo pannello del Ring —
registrato in parte dal vivo, in parte a porte chiuse —
valorizzandone con caparbia chiarezza, piuttosto che l'epicità
del decorso musicale, una singolare, commossa rarefazione (non
mancando magari qua e là di sottolineare con qualche
contraddittorietà la focosa violenza di taluni fff). Certi
impasti coloristici, certe pause, certa meditazione interiore
ottenuta con effetto dinamico eccelso da quella meravigliosa
orchestra che gli fa da sostegno, ottengono tutti di spostare
l'asse interpretativo sul piano dell'esautoramento di potenza.
Che non, è modo nuovissimo di accostarsi a quest'opera (fra
tutte quella che, con il Lohengrin, accampa con maggior risalto
i diritti della liricità), ma ottenuto con tale e tanta
esibizione di tecnica narrativa da ricavarne un musi. Ci sarebbe
solo da scegliere: la gravità, più dolente che corrusca, che
accompagna la solitaria confessione di Wotan nell'atto II; la
suprema tensione erotica che avvolge il dialogo dei fratelli
incestuosi nell'atto I; la magnifica sacralità
dell'annunciazione di morte fra Brünnhilde e Siegmund ancora
nell'atto II.
A ottenere siffatto esito non poco
contribuisce lo stellare cast che coadiuva la bacchetta. E
soprattutto il duo Kaufmann-Stemme. Credo che oggi Kaufmann si
possa reputare senza incertezze il più importante esemplare di
quel tipo di tenore che si usa definire lirico-drammatico; a ciò
contribuiscono diversi fattori, il primo dei quali attiene non
tanto al particolare fascino del colore (che ha sfumature
baritonali) quanto al magnifico uso che egli ne fa per sussidio
di una tecnica davvero fuori quota. La naturale brunitura,
valorizzata da un sistema di emissione e respirazione
eccellenti, gli consente di affermare una presenza oggi
difficilmente eguagliabile, tale da richiamare alla memoria
paragoni imbarazzanti, primo fra i quali quello con Lauritz
Melchior. E in questo Siegmund le testimonianze paiono
esemplari: fraseggio, legato, ampiezza degli armonici,
robustezza dei centri, tutto parla di un'eloquenza del dettato
narrativo di gran marca ove perfino le pause, intelligentemente
sfruttate, scolpiscono un personaggio indimenticabile. E non da
meno è la Brünnhilde di Nina Stemme, il cui profilo vocale di
bella austerità consona con le mire di Gergiev offrendo alla
vergine guerriera un alito di elegia lirica di rara bellezza. Il
che dimostra quanto fondato fosse, al di là degli stereotipi, il
richiamo di Wagner ai cantanti, durante le prove del primo Ring
a Bayreuth, «non mai recitativo, che non c'è nella mia musica,
ma canto ». La prova di questi due artisti stende dunque sulla
musica di Walküre un affascinante velo di malinconica
interiorità che fa giustizia di ogni vociferazione delle solite
e restituisce a Wagner quel clic gli compete, ovvero una
maestria del dettato canoro che troppi dimenticano e che il
direttore russo e i suoi protagonisti si ingegnano a
restituirgli.
Il terzo autorevole asse di tal visione
eterodossa è, sebbene con timida riserva, il basso René Pape,
grande fraseggiatore anch'egli, nei panni di un Wotan sottratto
all'imperio della regalità ad ogni costo. Non è chi non conosca
il magistero e il canto di rara morbidezza di questo basso; il
fatto è però che destrutturare I'archetipo potenza in un'opera
sì esposta al dominio dell'epico è un conto assai apprezzabile,
un altro è abbandonarvisi senza rete e per di più fruendo di
un'estensione in alto non sempre consona alla parte; e di finto
questo Wotan, che appare più rassegnato che imperioso, soffre
visibilmente di qualche inavvertibile carenza di peso, anche se
I'ottima tecnica lo trae quasi sempre fuor dei perigliosi gorghi
della scrittura, divisa equamente tra meditazione e furia. E
ovvio comunque che non mancano a Pape momenti di suggestione
intensa, che riscontriamo, pere un unico esempio, nel lungo
soliloquio, qua e là interrotto dalla figlia, dell'atto Il, il
cui finale « das Ende!» è un sussurro disperato di notevole
bravura. Il triplice asse, insomma, ha alla fine il suo perché.
Il rimanente del cast non esibisce, nel complesso,
altrettale perizia ma è ben lungi dall'essere manchevole, se si
eccettua forse lo Hunding di Mikhail Petrenko, il cui colore non
è mai scuro a sufficienza e la cui presenza si rivela tutt'altro
che minacciosa. Ma assai brava è Anja Kampe nell'offrire a
Sieglinde bellezza di colore e intensità d'espressione; e di più
che dignitoso impatto è infine la Fricka di Ekaterina Gubanova.
In quanto poi all'Orchestra del Mariinsky, tocca ribadirlo,
siamo al top dell'immedesimazione idiomatica. Un paese che, come
la Russia attuale, può esibire al mondo due compagini del
livello di questa e della compatriota di San Pietroburgo, sarà
pur un paese in crisi di identità e valori sociali, ma in fatto
di musica lasciamoli stare: i paragoni resterebbero impietosi
con buona parte del mondo occidentale.
|